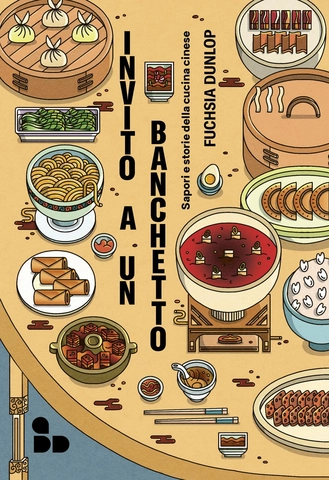Pechinese? Col Giappone siamo lì!
C'è un'immagine scolpita nella memoria collettiva italiana, più forte di qualsiasi saggio sociologico: il ragionier Ugo Fantozzi che invita a una cena romantica extraconiugale l’amata e irraggiungibile signorina Silvani, uno sketch tragicomico ambientato in un ristorante giapponese. Tra il divieto assoluto di usare le forchette (pena taglio delle mani), le triglie vive accettate con furore e per finire l'amato cane Pier Ugo servito come portata principale, quella scena raccontava una verità assoluta degli anni ‘70 e '80: per l'italiano medio, la cucina asiatica era un incubo incomprensibile. Un misto di crudeltà presunta e sapori alieni.
Per non parlare della confusione culturale. La carne di cane non viene consumata in Giappone, un giapponese inorridirebbe quanto noi di fronte all’arrosto fantozziano. È invece una prelibatezza in Vietnam, in alcune province del sud della Cina e in rare altre minoranze culturali del sudest asiatico. Non si cucinano poi cani di piccola taglia perché “c’è poca carne” (come ha commentato una volta una mia amica vietnamita), si cucinano razze canine più grandi, animali allevati specificatamente per la macellazione esattamente come facciamo noi con maiali, pecore e bovini.
Ma l’Asia è lontana e in una sorta di effetto prospettico tutto si appiattisce: Cina, Giappone, Corea e Vietnam entrano tutte nello stesso indistinto calderone, figlio anche di un bias razzista, di occhi a mandorla e bacchette. Infatti nella scena di Fantozzi è la signorina Silvani che introduce il cane Pier Ugo dichiarando proprio: “è un pechinese, che col Giappone siamo lì”. Con buona pace di culture millenarie profondamente diverse, con alle spalle secoli di guerre, invasioni e atrocità, ma anche di gastronomie incredibilmente distinte e complesse, forse ancor più di quelle europee.
Procediamo però con ordine, almeno storico.
I primi “contatti” con la gastronomia asiatica: un affare per pochi
Prima di diventare un fenomeno di massa, l'Asia in Italia è stata una questione d'élite, una curiosità per intellettuali e alta borghesia. Dimenticate gli involtini a due euro (o duemila lire). Il primo ristorante cinese in Italia, lo Shanghai, aprì a Roma nel lontano 1949. Si trovava in via Borgognona, nel cuore del lusso, ed era frequentato da personaggi come Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini. A Milano, la rivoluzione arrivò nel 1962 con La Pagoda in via Fabio Filzi. Fu un evento talmente rilevante che Dino Buzzati ne scrisse sul Corriere della Sera, celebrando il fatto che Milano fosse finalmente diventata una metropoli internazionale.
E il Giappone? Dobbiamo aspettare il 1977 e il genio del Maestro Shiro, che aprì prima un negozio di alimentari e poi negli anni ‘80 il Poporoya, primo vero sushi bar italiano. Prima di allora, l'idea di mangiare pesce crudo per un italiano era pura fantascienza.
L’invasione cinese degli anni '90
Poi, negli anni '90, quel mix di raffinatezza elitaria, disgusto e paura ha lasciato il posto alla “bastardizzazione” popolare. È arrivato “Il Cinese” sotto casa. Un luogo quasi archetipizzato, con l'acquario all'ingresso e le lanterne rosse, che ci ha servito per vent'anni una versione edulcorata e italianizzata dell'Asia: il riso alla cantonese (pieno di prosciutto cotto!), il pollo alle mandorle, il maiale in agrodolce (con l’ananas sciroppato in salsa rossa fluorescente), il "gelato flitto” (sic). Tutti piatti che non si sono mai visti in Cina.
Ci sono anche due importanti aspetti dietro questa omologazione. Da un lato l’aspetto demografico: per decenni, la quasi totalità dei ristoratori cinesi in Italia è arrivata dalla stessa, specifica zona (la città di Wenzhou e la contea di Qingtian, nello Zhejiang). Dall’altro l’aspetto della filiera: non esisteva un import di prodotti alimentari dalla Cina, gli immigrati dovevano abbandonare le loro erbe, spezie e verdure e arrangiarsi con quanto offriva il mercato italiano. Quella che noi chiamavamo genericamente “cucina cinese” era in realtà una versione povera e adattata delle abitudini di una singola provincia, replicata all'infinito da una migrazione a catena.
Sono insomma piatti di origine semplice e adattati al nostro gusto e al nostro mercato dell'epoca, standardizzati per un palato tutt’altro che raffinato; bastava che costassero poco e che sapessero di glutammato. Si trattava di una cucina “falsa”, italianizzata fino a caricarla di grassi e fritture che, come vedremo più avanti, sono agli antipodi della cultura gastronomica originale. Andare in un ristorante Cinese anni ‘90 e dire di aver “mangiato cinese” è come andare in un Pizza Hut a Los Angeles e dire di aver “mangiato italiano”.
L’era del Sushi
Ecco che nel 2000 le cose cambiano, ma il vero cavallo di Troia non sarà la cucina cinese, bensì il sushi. Esplode la nippon-mania, magari proprio perché diventa adulta la generazione cresciuta con cartoni animati giapponesi e manga, che si spande anche nel mercato della ristorazione.
La cosa ironica però è che saranno gli immigrati cinesi a proporre il sushi, togliendo gli acquari, le lanterne rosse e i dragoni di plastica dai propri locali, ri-arredando con stile minimal/zen e presentandosi come giapponesi, alzando con l’occasione anche i prezzi dei propri menù. La cultura gastronomica cinese è immensa e di alto livello, eppure le leggi di mercato sono ferree: gli italiani vogliono sushi. Provate ora a immaginarvi come emigrati italiani ad Hong Kong, costretti dal mercato a spacciarvi per francesi e servire solo escargot e zuppa di cipolle, nascondendo le tagliatelle e il ragù in cantina pur di lavorare.
C'è poi un'ulteriore capriola geografica in questa storia: molto del sushi creativo che troviamo ancora oggi nei nostri All You Can Eat (quello con il formaggio Philadelphia, il mango o le salse dolci) non ha nulla di giapponese. Arriva spesso dal Sud America o dagli USA. È figlio della diaspora giapponese in Brasile (la più grande al mondo) e delle mode californiane. Ci ritroviamo così, paradossalmente, a mangiare piatti nati a San Paolo o Los Angeles, preparati da mani cinesi, convinti di assaporare Kyoto o Tokyo.
Tuttavia, questo “inganno” ha funzionato: gli All You Can Eat hanno sdoganato il pesce crudo e consistenze nuove (le alghe, il riso colloso) al grande pubblico, facendo breccia sulla barriera di diffidenza culturale.
Il Ramen e il ritorno alle origini
Dal 2010 circa, il vento cambia ancora. Arriva il Ramen e scatta la scintilla. Improvvisamente capiamo che l'Asia non è solo sushi freddo, ma anche brodo caldo, grasso e nutriente. Smettono di aprire posti che fanno “Cina-Giappone-Thailandia” tutto insieme. Aprono le Ramen House. Si inizia a capire che ogni piatto ha una dignità e una complessità tecnica enorme (brodi cotti 12 ore, noodles alcalini, uova marinate). Perché anche solo il Giappone ha una cultura gastronomica regionale incredibilmente variegata: si estende dalle latitudini Siberiane ai tropici e ogni regione, città o provincia ha le sue tradizioni culinarie.
Durante un viaggio in Giappone, dopo aver vissuto le toccanti cerimonie del 6 agosto a Hiroshima, dovevamo muoverci verso l’isola di Naoshima, ad est. Ho letteralmente costretto la mia fidanzata a farsi 3 o 4 ore di treno aggiuntive per andare verso ovest a pranzo a Fukuoka, in cerca del vero ramen Tonkotsu, specialità di Fukuoka appunto. Lei me lo rinfaccia ancora, ma è un’esperienza gastronomica unica che rifarei anche domani.
Ma torniamo alla nostra storia. Sempre negli anni ‘10, fuori dai ristoranti, il mondo diventa ogni anno più globale, internet ci entra in tasca con gli smartphone, giovani e vecchi aprono gli occhi al mondo. L’Asia è sempre geograficamente lontana, ma il nostro cannocchiale culturale acquista un set di nuove lenti, in grado di vedere i dettagli, di distinguere.
I figli degli immigrati cinesi, nati e cresciuti qui, capiscono che non sono più costretti a friggere il gelato come i loro genitori, possono riappropriarsi della loro cultura originale, anche con orgoglio e soddisfazione (economica).
La differenziazione, finalmente
Nell’ultimo decennio abbiamo assistito alla nascita di ristoranti Vietnamiti, Coreani, Indonesiani. Ma non solo, anche i “cinesi” cominciano, almeno nelle grandi città italiane, a diventare di Pechino, di Chengdu o di Shanghai.
Perché la Cina ha un’estensione territoriale paragonabile a quella dell’intera Europa e il doppio della popolazione. In Cina ci sono due Europe stipate nello stesso spazio. La densità culturale e la stratificazione sociale sono immense, parlano anche lingue diverse, è vero che esiste il Mandarino come lingua ufficiale, ma non tutti la parlano e un abitante di Hong Kong potrebbe non riuscire a parlare con uno di Shanghai, così come un portoghese non capirebbe un danese. In questa nazione-continente le province sono grandi come le nostre nazioni: il Sichuan (che fra l’altro ha una rinomata tradizione culinaria) ha gli stessi abitanti della Germania, il Guangdong (Cantonese) ha 126 milioni di abitanti, più di Italia e Francia messe insieme.
Questa vasta eterogeneità ha prodotto ben 8 grandi tradizioni culinarie (Bā Dà Cài Xì), un concetto ben diverso dal nostrano "riso alla cantonese":
- Lu (Shandong): La cucina del nord, salata e imperiale, fatta di grano e frutti di mare.
- Chuan (Sichuan): Il regno del fuoco e del piccante “Ma-La” che intorpidisce la lingua.
- Yue (Guangdong/Cantonese): La cucina della freschezza estrema e dei Dim Sum.
- Su (Jiangsu): Raffinata, dolce, famosa per l'uso artistico del coltello.
- Min (Fujian): Sapori leggeri, agrodolci, zuppe complesse che uniscono mare e monti.
- Zhe (Zhejiang): Fresca e delicata, tipica della regione dei laghi e del pesce d'acqua dolce.
- Xiang (Hunan): Il piccante “secco” e affumicato, rustico e potente.
- Hui (Anhui): La cucina di montagna, fatta di erbe selvatiche, stufati e cibi della foresta.
Possiamo quindi anche dire che “ho mangiato cinese” è un po’ come dire “ho mangiato europeo”: non significa nulla. Oggi comincia a diffondersi la possibilità di esplorare gastronomicamente gran parte di queste culture (almeno nelle grandi città italiane).
Vivevo fino a un paio d’anni fa a fianco di uno dei vecchi “cinesoni”, di quelli ancora con lanterne rosse e draghi di plastica, con un menù che riportava gli involtini primavera e il riso alla cantonese. Il figlio del proprietario, però, inseriva spesso dei piatti del giorno che proponevano sapori veri della regione d’origine della sua famiglia. Ricordo con commozione una pancetta di maiale che si scioglieva in bocca, marinata con "delle erbe che mi faccio mandare dai miei parenti, che vivono sulle montagne sopra il Bacino delle Tre Gole”: un sapore affumicato unico. Ora quel ristorante ha chiuso e ogni giorno che passa mi viene sempre più voglia di visitare il Sichuan, alla ricerca di quello e di chissà quali altri sapori.
La specializzazione, ovvero la ricerca della perfezione
C'è poi un ultimo mito da sfatare: quello dei menù chilometrici con 150 voci numerate, dove si passa con nonchalance dal pollo alle mandorle al manzo piccante, dai nigiri giapponesi ai gamberi alla piastra, dall'anatra laccata al Khao Pad tailandese. Quella è un'invenzione commerciale per l'Occidente, nata dalla necessità di accontentare tavolate miste e palati indecisi.
In Asia, spesso la filosofia dominante è la verticalità, il “monopiatto”. Dimenticate il ristorante generalista, immaginate piccoli locali specializzati, in cui entrare per mangiare quel piatto. In Giappone questo concetto raggiunge vette quasi filosofiche, incarnate dalla figura dello Shokunin, l'artigiano che dedica l'intera vita a perfezionare un singolo gesto. Esistono ristoranti con stelle Michelin (come Torishiki o Bird Land a Tokyo) che servono solo Yakitori (spiedini di pollo). E basta. Niente sushi, niente ramen. Solo pollo grigliato con perfezione stellare.
Anche in Cina, seppur con sfumature diverse, la tradizione è simile: le raviolerie (Jiaozi House) fanno solo ravioli, le Noodle House tirano a mano solo spaghetti (Lamian), i templi dell'Anatra Laccata servono quasi esclusivamente quella. Questa verticalità è la base per una qualità elevata: scegliere un luogo specializzato significa abbandonare la comodità del “tutto e subito” per scoprire la profondità reale di una cultura. Significa capire che la cucina asiatica non è un genere unico, ma un universo di differenze, dove ogni piatto merita il suo palcoscenico esclusivo.
Oltre il gusto: una cucina orgogliosamente diversa
C'è però un livello ulteriore di comprensione, che richiede di abbandonare del tutto i nostri parametri di giudizio occidentali. Spesso pensiamo che la cucina cinese sia “pesante”, “unta” o poco salutare. Niente di più falso: quella è la versione da ristorante cinese anni ‘90 o da fast food.
A questo proposito è doveroso aprire una parentesi sulla famigerata “Sindrome da Ristorante Cinese”. Per decenni si è creduto che il glutammato monosodico aggiunto causasse mal di testa e malesseri. Tutto nacque da una semplice lettera aneddotica (e non da uno studio scientifico!) pubblicata nel 1968 sul New England Journal of Medicine. Da allora, la scienza ha ampiamente dimostrato che l'MSG (glutammato monosodico) è innocuo per la stragrande maggioranza delle persone. L'ironia della sorte? Il glutammato è presente naturalmente in concentrazioni elevatissime in molti cibi occidentali considerati eccellenze, come il Parmigiano Reggiano o gli altri formaggi molto stagionati, le acciughe o i pomodori maturi. Per non parlare del fatto che si trova in abbondanza anche nel latte umano (sì, proprio quello che vi ha nutrito il vostro primo giorno di vita): eppure, nessuno ha mai sviluppato alcuna “sindrome” da parmigiano o da latte materno.
La situazione è invece quasi inversa: come sottolinea splendidamente Fuchsia Dunlop nel suo “Invito a un banchetto” (un testo fondamentale per chiunque voglia capire davvero cosa succede oltre la Grande Muraglia), la cucina cinese è in realtà fondamentalmente basata sulla salute. Si fa ad esempio un larghissimo uso di vegetali, mentre la carne è spesso usata quasi come un condimento, un insaporitore per dare profondità e umami alle verdure.
Si tratta di un legame indissolubile tra alimentazione e benessere che noi europei abbiamo scordato e ricominciamo ora a re-imparare. Per un cinese non c'è confine netto tra dispensa e farmacia. Esiste il concetto di Yao Shi Tong Yuan ("cibo e medicina hanno la stessa origine"). Si mangia seguendo il clima e il corpo, bilanciando cibi “freddi” (yin) e cibi “caldi” (yang).
Un’altra affascinante barriera culturale da superare è la consistenza (Kougan): mentre noi occidentali siamo ossessionati dal sapore, in Cina la texture ha pari dignità. Le consistenze gelatinose, croccanti, scivolose o gommose (pensiamo ad esempio alle meduse, alle zampe di gallina, ai tendini) sono ricercate come esperienze gastronomiche superiori. Accettare che una cosa possa essere deliziosa non per il suo sapore, ma per come “si sente” in bocca, è forse l'ennesima differenza fra culture diverse, che se unite e “capite” possono darci molto di più.
Il miracolo della moltiplicazione
Torniamo al povero ragionier Fantozzi, che a conclusione della sua disastrosa cena con l’inviperita Silvani, cade in un delirio mistico dichiarando: “eccezionalmente, dal lago di Tiberiade, vi farò la moltiplicazione dei pesci e del riso… in bianco!”
Ecco, dopo quarant'anni, il miracolo è avvenuto davvero: il riso delicato e il pesce crudo hanno conquistato l'Italia, moltiplicandosi però in un universo di eccellenze e culture gastronomiche che si stanno oggi diffondendo anche da noi.
Abbiamo imparato a usare le bacchette.
Abbiamo, forse, finalmente intuito che non tutto ciò che è straniero e diverso debba essere tradotto: alcune cose vanno semplicemente assaporate e capite.